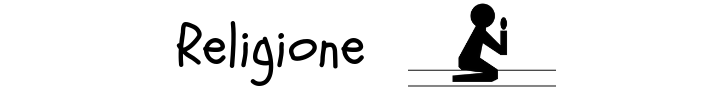
Indossare lo Hijab è un diritto primario che incide sull’identità personale esistenziale di una donna in base al suo credo religioso.
Farah, nome di fantasia, è italiana figlia di genitori egiziani. Professa la religione musulmana e per questo indossa il velo Hijab che copre i capelli e lascia scoperto il volto.
Nel 2013, riceve una proposta di lavoro per mansioni di volantinaggio da svolgersi in occasione della fiera della calzatura a Rho Fiera della durata di due giorni.
I requisiti dell’annuncio
Nell’annuncio di lavoro ricevuto via mail, l’hostess candidata ideale doveva avere bella presenza, conoscere la lingua inglese, avere un’altezza minima di 1,65 m, una taglia 40/42 e portare il n. 37 di scarpa. Questi i requisiti fondamentali richiesti.
Farah risponde all’annuncio in quanto possiede tutti i requisiti e nella mail di risposta, allega una fotografia.
L’agenzia che si occupa della selezione risponde a Farah facendole i complimenti per la bella presenza, ma chiede se è disponibile a lavorare togliendo lo chador.
Farah risponde che la sua volontà di portare il velo è determinata da una scelta religiosa e non è disposta a rinunciarvi, ma dovendo indossare una divisa, propone alla selezionatrice la sua disponibilità di abbinarlo alla divisa.
La società risponde che purtroppo i clienti non sarebbero stati “flessibili” e saluta la candidata non permettendole di partecipare alla selezione.
La società a sua volta è un’agenzia che si occupa di selezionare il personale, e in questo caso, seleziona figure hostess per un’altra società che invece parteciperà con uno stand all’interno della fiera, e che ha commissionato loro l’incarico, precisando altri dettagli nella sua ricerca: ovvero che la scelta finale della candidata, sarebbe spettata a loro.
L’agenzia doveva solo proporre una rosa di candidate con le principali caratteristiche menzionate, riducendo il tutto a una “preselezione”.
Farah non ci sta, e con l’aiuto del suo avvocato, porta l’agenzia in Tribunale.
In primo grado il Giudice, non rileva condotte discriminatorie dirette né indirette, in quanto l’esclusione di Farah dalla selezione, trova legittima richiesta del selezionatore di presentare al cliente, candidate aventi caratteristiche di immagine che non comportassero che venisse indossato alcun copricapo, qualunque esso fosse.
Tale argomentazione non è però condivisibile.
Una condotta è discriminatoria se determina in concreto una disparità di trattamento. Ai sensi dell’art.3 c.1, del D.Lgs. 9-7-2003 n. 261 “Il principio di parità di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età o di orientamento sessuale si applica a tutte le persone…” con specifico riferimento all’occupazione e al lavoro.
Si deve ritenere quindi che essendo il hijab un abbigliamento che connota l’appartenenza alla religione musulmana, l’esclusione da un posto di lavoro a ragione del hijab, costituisce una discriminazione diretta in ragione all’appartenenza religiosa.
Il non indossare il velo è dunque una giustificazione da ritenersi come determinante alla prestazione?
Il compito dell’agenzia era quello di fare una “preselezione”.
Quindi qui si mette in dubbio il requisito se una candidata sia idonea o no all’offerta di lavoro. Ma la società ha dato disposizioni sulla volontà che le sue hostess non dovessero avere indosso alcun copricapo?
Non emerge da nessun documento che il capo scoperto fosse un requisito essenziale e imprescindibile.
Al contrario era essenziale parlare inglese o portare il n.37 per indossare in fiera le scarpe come forma di marketing del prodotto offerto.
La Corte di Appello di Milano condanna in conclusione l’agenzia di selezione al risarcimento del danno in quanto riconosce la violazione di un diritto primario che incide sull’identità personale esistenziale dell’appellante.
Se vuoi conoscere la sentenza nel dettaglio richiedi attraverso la nostra pagina Contatti, la sentenza R1a (Corte di Appello di Milano, 20/05/2016, n. 579/2016 – RG. 1239/2014).

